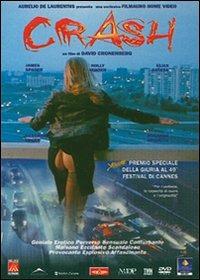La confessione di chitarrista turnista in tour più o meno perenne pubblicata su Guitar World andrebbe letta senza indulgenza e senza romanticismi. Non è lo sfogo di un musicista stanco, ma il racconto lucido di un sistema che ha imparato a consumare le persone mentre celebra i propri numeri. Vent’anni di tour bastano all’autore per smontare il mito del palco come luogo di libertà: quello che resta è precarietà strutturale, logoramento fisico e mentale, assenza di tutele spacciata per “passione”.
Il punto diventa ancora più evidente se lo si guarda dall’Italia. Qui la musica dal vivo è in ottima salute, almeno sulla carta: fatturati vicini al miliardo di euro, festival sempre più grandi, biglietti sempre più cari, pubblico in crescita. Il live è tornato a essere uno dei pilastri dell’industria culturale. Eppure questa espansione non sembra tradursi in un miglioramento delle condizioni di chi suona, lavora, monta, guida, regge tutto il carrozzone.
Il paradosso è ormai evidente: un settore che cresce economicamente ma resta fragile umanamente. La retorica del “se non lo fai tu, c’è la fila” continua a giustificare compensi bassi, contratti opachi e un’idea tossica di sacrificio permanente. L’articolo di Guitar World non punta il dito contro un singolo colpevole, ma contro un’abitudine: considerare normale ciò che normale non è.
Se il live è davvero il cuore pulsante della musica contemporanea, allora vale la pena dirlo chiaramente: non può reggersi all’infinito sulla resistenza individuale di chi lo anima. Senza un cambio di paradigma — meno retorica, più tutele, meno eventi-vetrina e più sostenibilità reale — il rischio è che dietro palchi sempre più scintillanti resti solo un ecosistema esausto. E a quel punto, i record conteranno poco.