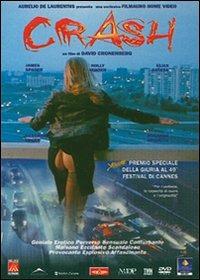
Crash di David Cronenberg del 1996 è uno di quei film che si ammantano di un'aura “radicale” per mascherare un vuoto concettuale che, a conti fatti, resta ostinatamente tale.
Travestito da provocazione filosofica sul rapporto tra corpo, tecnologia e desiderio, il film, ispirato all'omonimo romanzo di Ballard finisce per indulgere in una monotonia estetica e narrativa che scambia la ripetizione per ossessione e l’ossessione per profondità. La famosa freddezza cronenberghiana, qui, non diventa strumento di analisi ma posa: un gelo programmatico che anestetizza qualsiasi tensione emotiva e trasforma la visione in un esercizio di resistenza.
Il sesso legato alla violenza meccanica, alle cicatrici e agli incidenti d’auto dovrebbe aprire uno spazio perturbante, ma viene trattato con un’insistenza talmente piatta da risultare prevedibile. Ogni scena sembra una variazione minima della precedente, come se il film girasse in tondo attorno alla propria idea senza mai riuscire a superarla o a metterla davvero in crisi. I personaggi, ridotti a involucri apatici, non evolvono né si contraddicono: sono superfici su cui il regista proietta il suo teorema, e come tali restano freddi, intercambiabili, sostanzialmente inerti.
Anche la messa in scena, tutta acciaio, asfalto e interni spogli, finisce per appiattirsi in una monocromia emotiva che pretende di essere coerente ma suona più come povertà espressiva. Cronenberg osserva il suo mondo con distacco clinico, ma quel distacco non genera inquietudine: genera noia. Il film non scandalizza, non provoca, non mette in discussione; si limita a ribadire ossessivamente la propria tesi, convinto che la reiterazione basti a conferirle peso.
Crash resta così un’opera sopravvalutata, difesa più per ciò che rappresenta nel dibattito critico che per ciò che riesce davvero a essere sullo schermo. In realtà si tratta di un patinato, ma noioso, blando thriller erotico d'autore con qualche venatura porno soft.
Un film che pretenderebbe di scioccare, ma finisce per irrigidirsi nella propria pretesa intellettuale, lasciando allo spettatore non un senso di vertigine, ma la vaga impressione di aver assistito a un lungo, algido esercizio di stile.



